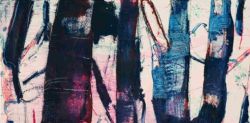La vera spiegazione
13 luglio 2025
XV domenica nell’anno
Luca 10,25-37 (Dt 30,10-14)
di Luciano Manicardi
In quel tempo 25un dottore della Legge si alzò per mettere Gesù alla prova e chiese: «Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?». 26Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella Legge? Come leggi?». 27Costui rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso». 28Gli disse: «Hai risposto bene; fa' questo e vivrai».
29Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è mio prossimo?». 30Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. 31Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e, quando lo vide, passò oltre. 32Anche un levita, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. 33Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. 34Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. 35Il giorno seguente, tirò fuori due denari e li diede all'albergatore, dicendo: «Abbi cura di lui; ciò che spenderai in più, te lo pagherò al mio ritorno». 36Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti?». 37Quello rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va' e anche tu fa' così».
Il primato della prassi: questa l’unità tra prima lettura e vangelo. La prima lettura (Dt 30,10-14) afferma che il comando di Dio è praticabile, anzi può e deve essere messo in pratica, altrimenti non viene adeguatamente compreso. Nei vv. 12-14 per ben tre volte, e sempre alla fine, ricorre il verbo ebraico casah, “fare”, riferito al comando (v. 11) e alla parola (v. 14), cioè all’intera legge mosaica, per indicare che essa può realmente essere messa in pratica. La Scrittura è data per essere vissuta: anzi, vivere la Parola è criterio per comprenderla. Meglio ancora: data per essere messa in pratica, la parola dà vita a chi la vive. Vivendo la parola si è generati alla vita. Dice altrove il Deuteronomio: “La legge non è una parola senza valore per voi, anzi è la vostra vita” (Dt 32,47). La pagina evangelica (Lc 10,25-37) mostra che si può sapere che l’intera rivelazione di Dio contenuta nella Scrittura si sintetizza nel comando di amare Dio e il prossimo ma non trarne le conseguenze ed eludere la prassi. Dicendo “Hai risposto bene (orthôs); fa’ questo e vivrai” (Lc 10,28), Gesù incita il dottore della Legge a passare da una sterile ortodossia all’ortoprassi, unico piano di autentificazione della comprensione delle Scritture. La vera esegesi della parola biblica non consiste in un commento scritto o orale, ma nella prassi: la parola biblica chiede di divenire corpo, vita, relazioni, gesti. E di fronte alla domanda: “Chi è il mio prossimo?”, Gesù narra la parabola del Samaritano anch’essa ben compresa dal suo interlocutore, ma la conclusione di Gesù è la medesima: “Va’ e anche tu fa’ lo stesso”. Come Gesù, in quanto parola fatta carne, è l’esegesi piena della parola di Dio, così il credente commenta la Scrittura vivendola, dandole carne e facendola avvenire nel suo corpo. Emerge così che i sensi di ogni parola biblica non sono solo settanta (il testo rabbinico Alfabeto di Rabbi ‘Aqiba afferma che ogni parola della Torah ha settanta sensi), ma tanti quanti sono gli esseri umani che, ciascuno nella propria unicità, cercano di attuarla. Vi è un’esegesi che ciascuno è chiamato a fare della Scrittura e che lui solo può compiere. L’ascolto della Parola tende a coinvolgere e trasformare il corpo del credente, chiamato ad amare Dio con tutto il cuore, con tutta l’anima, con tutte le sue forze e il prossimo come se stesso.
Il vangelo si apre mettendo in scena un “dottore della Legge” che interroga Gesù su che cosa fare per ereditare la vita eterna (cf. v. 25). La domanda ha in vista la vita del mondo futuro. Gesù risponde mettendo in atto dei gesti di trasmissione di eredità: egli rende cosciente il suo interlocutore del testamento che ha alle spalle e che già illumina la sua via. E gli indica come far tesoro di tale testamento. Gesù infatti rinvia alla Torah (“Nella Legge, che cosa sta scritto?”: v. 26) e aggiunge una domanda che coinvolge personalmente il dottore della Legge: “Tu, come leggi?” (v. 26). Gesù consegna un testo e una domanda, o meglio rimanda al testo che è, da un lato, il testimone per eccellenza della volontà di Dio, e dall’altro, il testamento che si rivolge con la sua promessa di vita al dottore della Legge (come a ogni altro lettore della Torah): per te è questa parola, dice Gesù quasi echeggiando il testo del Deuteronomio. E alla risposta del dottore della Legge (v. 27), Gesù aggiunge l’indicazione a fare ciò che la Torah prescrive, ovvero ad attivarsi per rendere effettiva l’eredità (v. 28). Il meccanismo di trasmissione viene ripetuto subito dopo. Il dottore della Legge interroga nuovamente Gesù il quale gli consegna una narrazione, questa volta un testo orale (la parabola del Samaritano: vv. 29-35), quindi una domanda che coinvolge l’interlocutore (v. 36) e infine l’indicazione pratica, il comando di agire (v. 37). Gesù sta facendo opera di trasmissione. E non si lascia frenare dalle intenzioni poco limpide che sottostanno alle parole del suo interlocutore (che prima lo interroga “per metterlo alla prova”, quindi “per giustificarsi”: vv. 25.29). Una domanda esige una risposta: la responsabilità di chi è interrogato è di rispondere. Questa la responsabilità di un genitore davanti al figlio, di un maestro davanti a un discepolo: una responsabilità generativa. In cui non è importante l’intenzione di colui che ha chiesto, ma l’onestà e l’integrità di colui che risponde. Anzi, la prima risposta-testimonianza è proprio quell’onestà e quella integrità. Qui Gesù si comporta come un maestro: e un maestro in-segna, fa segno, indica, consegna simboli che aiutino a orientarsi nella realtà. Opera una trasfusione di memoria, àncora il discepolo a un passato mostrandogli che questo non lo incatena ma anzi proietta luce sul futuro e lo fa camminare verso tale futuro. Il maestro si appoggia e fa riferimento a una tradizione rendendola viva e significante per la persona che ha davanti, per il suo oggi e per il suo futuro. Come avviene nell’episodio in cui Gesù incontra un notabile che lo interroga in modo analogo al dottore della Legge: “Maestro buono, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?” (Lc 18,18). E Gesù fa opera di trasmissione consegnando un testo (rinvia l’uomo alla Torah: 18,20), una domanda (“Perché mi chiami buono?”: 18,19) e infine un’indicazione pratica circa il “che fare”: “Vieni, seguimi” (18,22).
Alla seconda domanda del dottore della Legge, Gesù risponde con un racconto. Gesù è un narratore e la narrazione, che normalmente avviene sotto forma di parabole, è la modalità mite con cui Gesù invita l’interlocutore a lasciarsi ferire, a leggersi in verità e a cambiare il proprio atteggiamento e orientamento di vita. Le parabole non hanno un fine informativo, ma trasformativo. Con la parabola del Samaritano, che mette in scena anche un sacerdote e un levita che mostrano incoerenza tra appartenenza religiosa e solidarietà verso chi è nel bisogno, Gesù urta probabilmente la sensibilità dell’interlocutore, che è un dottore della Legge. Ma in modo tale che si senta coinvolto senza essere respinto. E anche questa pagina di vangelo ci pone di fronte a un tratto ricorrente dell’umanità di Gesù, che possiamo definire sovversiva. Gesù supera confini, varca soglie, abbatte tabù: in svariati ambiti Gesù non si attiene a confini prefissati e oltrepassa frontiere e limiti, barriere culturali e tabù stabiliti da tempo sia sul piano sociale che religioso. Se altrove supera la rivalità che divideva la comunità giudaica e quella samaritana (Gv 4,1-42), qui mostra che il Samaritano, figura a volte demonizzata (“Tu sei un samaritano e un indemoniato”: Gv 8,48), è in realtà capace di quel comportamento umano che costituisce la risposta alla domanda del dottore della Legge: proprio lui, infatti, si mostrerà essere il prossimo dell’uomo ferito. E il dottore della Legge lo riconoscerà (Lc 10,37). La storia narrata da Gesù l’ha preso per mano e condotto là dove non sarebbe forse mai arrivato se si fosse rimasti nello spazio delle discussioni di scuola.
Al cuore della parabola vi è la risposta mossa da compassione che il Samaritano dà all’uomo ferito lungo la strada. La fragilità di quest’uomo, come sempre la fragilità di una persona malata, povera, menomata nei tanti modi con cui la vita e gli umani infieriscono su altri, è una domanda. Una domanda che interpella e chiede una risposta. Che potrà essere etica o di indifferenza o perfino di rifiuto e di odio. Una domanda che mette alla prova la nostra umanità. La verità universale del racconto evangelico la trovo presente nelle parole del poeta persiano Sa’di (XIII secolo) esposte su un muro del palazzo dell’ONU a New York: “I figli dell’uomo sono membra dello stesso corpo / create dalla medesima essenza. / Quando la sventura getta un membro nel dolore, / alle altre membra non resta più riposo. / Oh tu, che non ti curi del dolore altrui, / non meriti di essere chiamato uomo!”. Il Samaritano non è un eroe, ma un uomo. La retorica epica dell’eroe che lo innalza a vertici inarrivabili da parte dell’uomo comune è tra le cause della passività dei più. Il Samaritano non è un eroe, ma un uomo comune che ha saputo dare risonanza interiore alla situazione disgraziata dell’uomo (a lui sconosciuto) ferito e ha deciso di rispondervi attivamente. La psicologia sociale ci ha insegnato che alla banalità del male si accompagna anche “la banalità della bontà” (Philip Zimbardo), non nel senso che fare il bene sia cosa banale, ma che fare il bene anche in condizioni estreme e a rischio della propria vita è cosa possibile, praticabile da parte di persone semplici, da parte dell’“uomo comune”: è una potenzialità insita nella creatura umana. “Non troppo alta o distante o lontana da te, ma che abita in te”, potremmo dire parafrasando Deuteronomio. Di fronte a chi è nel bisogno, in noi sorgono domande, esitazioni, lotte interiori sul da farsi. La domanda che dovrebbe prevalere non è “che cosa mi succede se mi fermo?”, ma: “Che succede a lui se non mi fermo?”. E forse, dopo, si potrà dire qualcosa di simile a quanto disse Irene Sendler, donna polacca che salvò quasi 2500 bambini ebrei dai nazisti facendoli uscire con stratagemmi dal ghetto di Varsavia, quando nel 2007 fu onorata dal governo polacco per i suoi atti eroici. Novantasettenne, non poté partecipare alla cerimonia, ma inviò una lettera in cui scrisse: “Ogni bambino salvato grazie all’aiuto mio e di altri è la giustificazione della mia esistenza, non un titolo di gloria”.